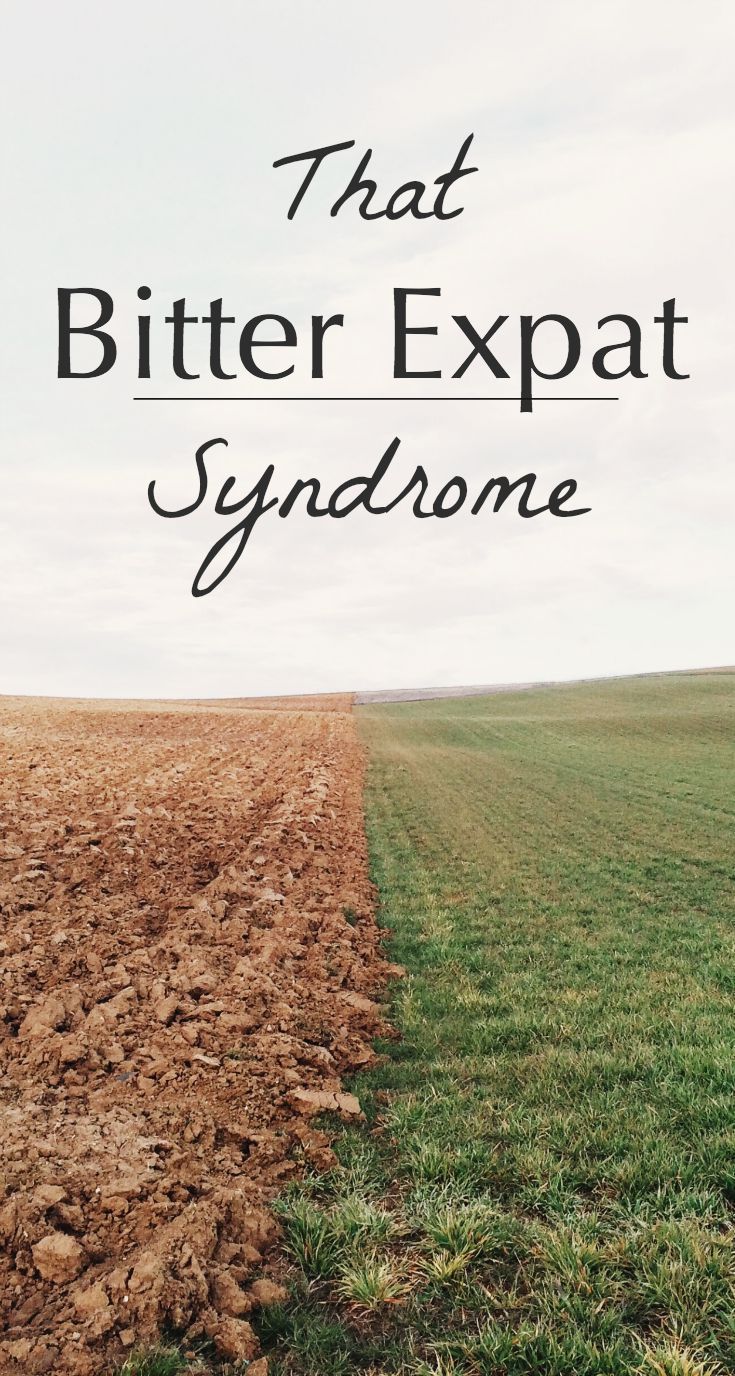
Come sapete, periodicamente, per brevi slots e parallelamente ai programmi di formazione e orientamento alle Aziende, Organizzazioni e Istituzioni educative, offro consulenza e Mentoring individuale 1:1 a chi sentisse il bisogno di fare chiarezza nel proprio percorso professionale e/o personale, soprattutto nel contesto di cambiamenti culturali, lavorando in profondità per offrire un modo nuovo di pensare ed immaginare la diversità in tutta la sua complessità.
In questo ultimo ciclo (che terminerà domani) ho avuto il privilegio di lavorare con Enrico Maria (che qui mi rilascia totale libertà di condividere il nostro lavoro insieme), un ingegnere di Vicenza che, dopo una lunga esperienza in alcuni stati Africani, ha deciso di fermarsi in Nigeria ed iniziare una nuova vita, fatta di stabilità e qualche responsabilità in meno.
Mi contatta, però, perché sta vivendo un periodo particolarmente complicato, fatto di confusione, incertezza, a tratti di paura, pur essendo consapevole del fatto che emigrare è un evento che incide profondamente nella vita di chiunque, e che rappresenta un’esperienza con tanti cambiamenti che occorre affrontare. Conoscere persone con una cultura diversa, inserirsi in una nuova città, vivere in una casa nuova e delle volte dover imparare un’altra lingua per poter comunicare nel nuovo contesto sono cambiamenti importanti che portano con sé un’esperienza emotiva molto intensa, che implica la necessità di affrontare ed elaborare numerose perdite a livello individuale, familiare e sociale, connesse a diverse tipologie di separazioni: separarsi dal proprio paese d’origine, dai legami costituiti durante tutta la vita, dalla famiglia, dagli amici ecc.
Pochi, normalmente, sono consapevoli che esiste un fenomeno chiamato lutto migratorio o lutto culturale ed i suoi effetti sono ancora più distruttivi perché non è sancita, né formalmente convalidata. Viene comunemente considerata in una dimensione più estesa, in ambiti patologici o in condizioni mediche più ampie sotto il nome di depressione, emicrania cronica, disturbi psicosomatici. In realtà si tratta di un dolore legato alla separazione dal proprio paese, dolore dovuto anche alla consapevolezza di ciò che si è lasciato. Si sperimenta la perdita profonda dei legami con i contesti in cui si è nati e cresciuti, con i punti di riferimento sociali e culturali. Questo comporta un processo di revisione e risignificazione del proprio vedersi al Mondo. Si tratta di un lento e complesso processo di riorganizzazione interna, un processo di adattamento alla nuova realtà.
“Ulisse trascorreva i giorni seduto sulle rocce, sulla riva del mare, consumandosi a forza di piangere, sospiri e dolori, fissando i suoi occhi nel mare sterile, piangendo instancabilmente…”
(Omero, Odissea, Canto 150)
Omero descrive bene questa condizione quando narra lo struggimento di Ulisse che vorrebbe tornare agli affetti familiari ed alla nativa Itaca. L’odio di un dio avverso – Poseidone – glielo impedisce costringendolo a girovagare per 20 anni prima di poter tornare a casa.
Il concetto di lutto culturale si inserisce nel contesto più ampio delle perdite che non possono essere facilmente definite o circoscritte, e che quindi rientrano nella categoria di ciò che la psicologa Pauline Boss ha definito “perdita ambigua”. Si tratta di un’esperienza profondamente psicologica e simbolica, caratterizzata dalla sensazione che qualcosa di importante sia stato perso, ma in un modo indefinito o parziale. Indica una perdita che non è chiara, definitiva, e che non ha nessuna risoluzione, determinando così una sofferenza che non ha possibilità di chiusura. La natura della perdita è sfumata, non è chiaramente riconoscibile o è complessa da comprendere, è una condizione paradossale di presenza/assenza di una persona cara e costituisce perciò un lutto che rimane irrisolto. Originariamente il termine è stato utilizzato per indicare la condizione dei familiari di soldati dispersi in combattimento, ma può essere applicato a diverse situazioni.
Un lutto parziale, dicevo, perché le perdite non sono mai definitive ma ricorrenti. Il paese d’origine, la famiglia, gli amici, non sono persi per sempre, perché il migrante può farvi ritorno. E’ un lutto ricorrente perché si rinnova ad ogni partenza dal proprio paese d’origine. Ed ancora, un lutto speculare poiché i familiari del migrante vivono un analogo – anche se solitamente meno intenso – processo di lutto della persona che ha deciso di emigrare. Il tutto nel nome del tempo, inteso come tempo trascorso lontano dal proprio paese d’origine, e dello spazio inteso come distanza tra il luogo di vita ed il paese d’origine. Più tempo e più lontani si vive dal proprio paese d’origine, più il lutto migratorio può ridursi d’intensità o essere intenso, ma non sparisce mai del tutto, accompagnando la persona per tutta la vita..
La perdita ambigua è considerata la più devastante e disfunzionale delle perdite per l’incertezza e l’ambivalenza che la caratterizzano ed è maggiore il rischio che si instauri un lutto patologico perché il processo di elaborazione è paralizzato: si tratta di un lutto “stagnante”. Purtroppo la persona stessa che vive la perdita ambigua non è consapevole di vivere un lutto – anzi, di più, il più difficile tra i lutti – e si colpevolizza per i propri sentimenti ambivalenti. Non solo quindi si tratta di un lutto “senza diritti” perché non sancito socialmente, ma anche la persona stessa che lo vive non legittima la propria sofferenza.
Nel caso del lutto culturale, l’ambiguità nasce dal fatto che la cultura stessa, come costruzione sociale e simbolica, è complessa e stratificata. Quando una persona si trova sradicata dal proprio contesto culturale o impossibilitata a riconnettersi pienamente con le proprie radici culturali, la perdita si manifesta come una mancanza di appartenenza, ma anche come un’assenza che non può essere facilmente localizzata o definita.
Questo tipo di perdita è particolarmente complesso perché la cultura, per sua natura, non è mai completamente assente: essa continua a manifestarsi attraverso tracce, simboli e memorie. Tuttavia, l’accesso completo a questa cultura potrebbe essere precluso, ad esempio, a causa di migrazioni, assimilazione forzata, o perché si tratta di una cultura ereditata ma mai vissuta in prima persona. Questo crea una situazione di presenza incompleta e di assenza latente.
L’incertezza rende la perdita ambigua la più disfunzionale di tutte le perdite e comporta sintomi non soltanto dolorosi ma spesso difficili da diagnosticare. Scaturisce dalla mancanza di certezza sulla presenza o assenza di una persona e dall’angoscia derivante dalla nostra costante ricerca di coerenza: persino la certezza della morte è più accettata della continuità di un dubbio. Le perdite ambigue si riscontrano non soltanto nei contesti di guerra e di violenza ma insidiosamente anche nella nostra quotidianità. Compagni che ci lasciano, figli che se ne vanno di casa, genitori ammalati e mentalmente assenti. La nostra sete di certezza assoluta è raramente soddisfatta, perfino nelle relazioni che riteniamo stabili e prevedibili. Inoltre, maggiore è la cortina di ambiguità intorno ad una perdita, più grandi saranno le difficoltà a dominarla ed i conseguenti stati di ansia, impotenza, depressione e conflitti relazionali.
La traiettoria dell’esperienza dopo una perdita culturale differisce dalla maggior parte dei modelli di lutto esistenti. A differenza della morte, per esempio, la perdita indefinita impedisce quel “taglio netto” necessario per una normale chiusura. Il lutto è rappresentato come una risposta a un evento specifico, in genere la morte di una persona cara. Ripercorrere la persona nella propria mente e riflettere sulla sua vita e sulla sua eredità sono tutti elementi considerati cruciali per elaborare la sua perdita. Come il processo di elaborazione del lutto stesso che è l’adattamento in cui riconfiguriamo il nostro modo di intendere e agire nel mondo in loro assenza. Così come l’ambiguità complica la perdita, rende altrettanto difficile l’elaborazione del lutto in quanto non è una perdita reale. La confusione cristallizza il processo di elaborazione del lutto, fino a paralizzare la persona, impedendo alla sua vita di evolversi.
Nel lutto culturale, i confini della perdita sono sfocati:
- Cosa è stato perso? Non si tratta di una perdita materiale, ma di elementi intangibili come linguaggi, tradizioni, credenze o modalità di relazione con il mondo.
- Dove è stato perso? La perdita non è legata a un luogo specifico, ma a uno spazio simbolico che può essere geografico, mentale o emotivo.
- Quando è avvenuta la perdita? Spesso non c’è un momento preciso: la perdita può essere graduale, transgenerazionale, o sentita solo retrospettivamente.
La perdita ambigua comporta spesso sentimenti di:
- Disorientamento identitario, poiché la cultura contribuisce a definire chi siamo.
- Mancanza di chiusura, dato che la perdita non può essere risolta o “elaborata” nel modo tradizionale.
- Nostalgia complessa, che non è solo il desiderio di tornare a un luogo o tempo passato, ma un senso di vuoto per qualcosa che non è mai stato completamente vissuto. In sintesi, il lutto culturale sottolinea l’importanza della cultura come elemento costitutivo dell’identità umana e rivela quanto profonde possano essere le ferite causate da una perdita indefinibile e ambigua.
Ecco che Enrico Maria si trova in una perturbazione sulla membrana di una perdita, di per sé così singolare e strana, che non so come considerarla. E’ consapevole del fatto che il dolore sia un universale umano, ma questo specifico tipo di lutto culturale, nella letteratura contemporanea sul lutto, è trascurato e pochi sono in grado di dare uno spunto per attenuare il disagio. Enrico Maria trova difficile persino descrivere le perdite legate allo sradicamento, alla perdita dell’accesso a una cultura che non ha mai conosciuto appieno. Eppure qualche sua riflessione sul fenomeno mi ha particolarmente colpita. Una in particolare quando descrive un dolore sfocato, amorfo che si proietta nella creazione di un’atmosfera in cui i suoi pensieri e le sue emozioni vanno alla deriva e a spirale. Gli riesce difficile individuare ciò che è effettivamente scomparso poiché vive eventi multipli che si verificano su lunghe distanze e su tempi lunghi e che modellano o rompono il mondo di vita condiviso di una comunità. La sua piena sensazione è quella di essersi sì adattato al nuovo contesto in modo naturale, ma in fondo infondo sente un disagio che non sa ben definire e, conseguentemente gestire.
Abbiamo deciso insieme di non pensare a questa perdita in termini di oggetto, concreto o ambiguo, ma guardare al soggetto che la subisce, cioè, appunto, Enrico Maria. Lasciare il proprio Paese e ricostruire la propria vita sono quelle che chiamo esperienze trasformative, che cambiano radicalmente le persone che le subiscono. A differenza di cambiamenti più superficiali come tingersi i capelli o (in molti casi) ottenere un nuovo lavoro, le esperienze trasformative sono quelle che creano cambiamenti duraturi nella prospettiva e nei valori di chi le subisce. Possono essere esperienze profondamente significative che rinnovano il proprio mondo. Come migrante, Enrico Maria si è trovato alle prese con la scelta di mantenere il tipo di ruoli e relazioni familiari e comunitarie che aveva nel suo Paese d’origine. In questo processo, non ci si limita ad acquisire nuove intuizioni o riflessioni, ma si devono rielaborare i fondamenti di ciò che si è: ciò che si apprezza, ciò che si considera importante o prezioso e la base su cui si prendono le decisioni.
Crescendo in una comunità montana veneta, particolarmente chiusa e tradizionalista, le dimensioni etiche della sua identità culturale gli si sono state esplicitamente impresse. Abbiamo così discusso su come sia meglio orientarsi e adattare le nuove norme culturali alle sue circostanze. Mettere in discussione le norme con cui si vive la propria vita può provocare dolore proprio perché attorno a quella vita abbiamo formato un’identità. Ma è un identità che Enrico Maria comincia realizzare di non aver mai saputo che farsene.
I valori e gli impegni associati alla sua identità culturale gli sono stati insegnati e sottolineati, ma non è mai stato sicuro di cosa farne. Ciò che era “nostro” veniva spesso usato per guidare il comportamento, ma ciò che “noi” facciamo e non facciamo sembrava estendersi in direzioni arbitrarie: dal non indossare certi tipi di gioielli al non festeggiare Halloween, per esempio. Non è mai stato qualcosa che potesse racchiudere nella sua mente come un insieme di norme chiare e prevedibili.
Si è reso conto delle pressioni esterne e interne di “dover capire chi sei e allo stesso tempo dire a tutti chi sei” per definire la propria identità culturale, problema che non si era mai posto sino a qui. Ed è qui che (probabilmente) nasce il suo vero disagio: trovarsi, per la prima volta in vita sua, a resistere alla canonicità, a lasciare che la cultura nigeriana si integri. Sperimenta quel famoso clichè dell’esperienza degli immigrati cioè quello di essere “a metà strada” tra due culture, di non riuscire a inserirsi pienamente in nessuna delle due e di sentirsi perennemente fuori o alla periferia. “Sono la terza riserva, mi fanno giocare raramente, sono per lo più in panchina. Ma sono ancora in squadra” – dice.
Quindi abbiamo convenuto che il suo disagio deriva in parte dalla “betweenness”, ma sicuramente anche dal fatto che l’esperienza della migrazione ti costringe a confrontarti con la natura contingente dell’identità molto prima di quanto facciano gli altri. Prima di quanto chiunque dovrebbe fare, in realtà. Ci si sente sottoposti a una forte pressione per creare, curare e scegliere ciò che si avrebbe preso da ogni mondo a cui si è esposti (una modalità di formazione dell’identità decisamente occidentale). La sua auto-identità era così contestata e sembrava che molto dipendesse dalle decisioni che prendeva. “È come se fossi in piedi su un binario di collegamento, incerto su dove andare” – spiega Enrico Maria dopo le nostre sessioni di Mentoring – “Essere costretto a riflettere costantemente sulle norme culturali e a relativizzarle mi ha dato la sensazione di essere un’osservatore perenne, nemmeno in panchina, ma sugli spalti”.
Affrontare le basi fragili e contingenti della propria autostima è un’altra caratteristica centrale del lutto. Costruiamo la nostra vita su persone e luoghi che non sono eterni, ma per la maggior parte della nostra vita spesso ignoriamo questo fatto. Quando queste persone e questi luoghi scompaiono, non abbiamo altra scelta che affrontare la fragilità della nostra identità. Dobbiamo fare i conti con il modo in cui i nostri valori sono collegati alle persone e alle cose, e con quanto sia tenue il filo che tiene insieme il tutto.
Il dolore della contingenza è particolarmente disorientante per chi è culturalmente in lutto. La realtà è che le pratiche culturali hanno una grande dose di casualità. Ci si veste di nero dopo un decesso; si serve pesce perché il giorno del santo cade di mercoledì; ci si siede in veranda con il vicino, bevendo caffè nero addolcito con zollette di zucchero. Eppure anche questi rituali sono costruiti su un’illusione di necessità.
“Da bambino mi è stato insegnato che queste pratiche (ospitare il vicino, vestirsi di nero), costruite su questi concetti (casa, comportamento), sono il modo in cui si incarnano questi valori (ospitalità, generosità, pietà)” – Enrico Maria
Quando questa operazione non può essere data per scontata, quando si rivela non essere né naturale né necessaria, si perde un terreno certo su cui crearsi come soggetto etico. Ma c’è un concetto di speranza radicale che può ancora illuminare la struttura del lutto culturale. Le situazioni di sofferenza possono favorire il sorgere della speranza, grazie alla quale ci apriamo al possibile, rappresentato dalla trasformazione personale e dalla costruzione di un nuovo senso. La speranza è quindi un’attesa attiva che ci fa agire nel tempo, diversa dall’attesa passiva nella quale aspettiamo che qualcosa e il tempo vengano verso di noi. La speranza non è guardare avanti solo con ottimismo, ma soprattutto guardare al nostro passato e comprendere come giocarlo in nuove possibilità.
Nel lutto culturale, come nella speranza radicale, una persona è diretta emotivamente verso qualcosa che non può comprendere appieno. Io soffro per le perdite legate alla migrazione, alla mia cultura, alla mia famiglia. Tuttavia, le mie emozioni non si aprono su quelle perdite specifiche, come una finestra si affaccia su una strada. Nel lutto, una perdita prende forma rispetto alla mia vita attuale, soprattutto in termini di ciò che mi sta a cuore, di ciò che mi definisce e di ciò che è importante per me. Poiché questi elementi sono in continua formazione, non so bene quale sia il significato della perdita. Eppure mi addoloro, sapendo che è significativa.
C’è anche un secondo tipo di speranza che riguarda la perdita culturale, quella assoluta. Questa non è rivolta a nessun risultato specifico. È un’attesa aperta e paziente del bene, che può essere conosciuto solo quando lo si sperimenta. Quando abbiamo pazienza per un’altra persona, rispettiamo il suo ritmo interno. Non cerchiamo di costringerlo a seguire il nostro ritmo, né lo abbandoniamo a se stesso. Abbiamo fiducia nell’altra persona in un modo che rispetta il suo ritmo. È questa qualità della pazienza, del non avere fretta, che è rilevante per il processo di trasformazione dell’identità nel lutto culturale.
Generalmente, all’interno della diaspora, c’è un sacco di modellamento e un sacco di adattamento alle cose, piuttosto che la libertà di presentarsi con tutto se stessi, di presentarsi così come si è”. Il dolore culturale si collega alla speranza in quanto, come la speranza radicale e assoluta, è diretta a un oggetto che diventa più chiaro solo quando trasformiamo pazientemente la nostra prospettiva. Ci si sente come se il proprio “io”, qualunque cosa sia, sia troppo piccolo, troppo fragile, per sopportare le forze della cultura e della storia che contendono una persona. Ma ciò con cui ci si confronta e che affrontiamo tutti prima o poi sono i vuoti, le differenze, la casualità di ciò che siamo. Può essere doloroso, ma dall’altra parte di questo interrogatorio si ha la soddisfazione di un sé che è veramente proprio, di un sé che è stato pensato e creato attivamente.
C’è anche da dire, infine che non tutti i migranti (chissà perché se la migrazione riguarda gli occidentali si chiamano “expat”) vanno incontro a questa sindrome di Ulisse dove il processo di elaborazione di lutto si blocca e si possono manifestare sintomi di tensione, irritabilità o distorsione della realtà che possono portare a vedere il nuovo Paese come un nemico che ci ha causato solo distruzione e sofferenza, un posto orrendo dal quale si vuole fuggire, non rendendosi conto che la vera causa del proprio malessere non proviene dall’esterno ma da noi stessi.
Di fronte a tale sintomatologia è importante da un lato non sottovalutare la presenza di tali “campanelli d’allarme” che segnalano la presenza di un forte disagio, né medicalizzare diagnosticando una patologia mentale che non c’è. I sintomi della sindrome di Ulisse possono assomigliare a quelli di altri quadri sindromici ma in realtà si tratta di una grave condizione di stress. Il primo passo da compiere é riconoscere questo disagio dentro di sé. La presenza di un professionista può aiutare la persona a superare la fase di “impasse” nell’elaborazione del lutto ed affrontare questa fase della vita attraversando un lungo processo di riorganizzazione interna dove dovrà accettare le perdite subìte, controbilanciandole con gli obiettivi da raggiungere nella nuova realtà. Dove dovrà integrare i sentimenti positivi e negativi, i vissuti passati e presenti in un’identità nuova.
Luisa Casagrande | Senior Mentor & Trainer Métissage Dynamics© | Autrice di
We develop experiences that make people’s lives simple.

